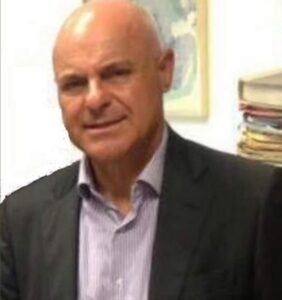Lo scioglimento della Fondazione Corrado Alvaro da parte della Prefettura di Reggio Calabria pone una serie di rilevanti questioni che, per il loro spessore, meriterebbero di essere tutte vagliate approfonditamente. Vengono in mente i temi dell’esercizio e dei limiti delle potestà pubbliche, delle modalità della promozione culturale, dei tentativi di attivarsi da parte della cittadinanza attiva, del recupero delle aree e dei centri interni, nonché, inevitabilmente, dei metodi di contrasto alla criminalità mafiosa e della loro efficacia; tutto infatti è accaduto a San Luca, paese trattato ormai solo sotto una certa ottica, persino quando si parla di libri e di cultura, persino quando si parla di Corrado Alvaro, scrittore ed intellettuale dai vasti orizzonti sovranazionali in un’epoca di nazionalismo autoritario e tragico. La più urgente delle riflessioni non può non cadere sulla legittimità di un provvedimento adottato da una Prefettura nei confronti di una Fondazione, istituita con la legge regionale n. 20/1995, del cui C.d.A., tra gli altri, fanno parte la Regione Calabria, la Città metropolitana ed il Comune di San Luca. Non c’è dubbio che l’effetto demolitorio del provvedimento ha inciso anche le sfere di competenza esclusiva degli enti appena citati, i quali però, vista la loro assenza di reazioni, sembra non se ne siano accorti. Eppure, è un dato ormai acquisito che il legislatore costituzionale con la Riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione ha riconosciuto la piena compartecipazione alla unità e indivisibilità della Repubblica, con pari dignità costituzionale, ai Comuni, alle Province e alle Regioni.
Il punto di equilibrio del nuovo ordinamento dei pubblici poteri è stato così profondamente modificato ed oggi lo si raggiunge muovendo dal basso verso l’alto, partendo dalle istituzioni e dalle formazioni sociali più prossime ai cittadini, secondo i principi della sussidiarietà sia orizzontale che verticale. Non è un caso se, a tale riforma, è seguita anche l’abrogazione delle disposizioni relative ai Commissari di governo e agli organi regionali di controllo, e, più in generale, ai controlli di legittimità sugli atti degli enti locali. Alcuni autori, commentando questo nuovo scenario istituzionale, hanno parlato di rarefazione dei tratti autoritativi delle funzioni delle Prefetture, alle quali è stato aperto un campo nuovo e vasto, tendente a promuovere in particolare l’autoresponsabilità civica, attraverso sollecitazioni, convocazioni, stipulazioni di impegni e di accordi; possibilità che, nel caso che ci occupa, non sembra siano state attivate. Prima di passare al merito delle rilevate criticità, suscita perplessità la comparazione tra la brevità dell’arco temporale delle “criticità” rilevate – 2019/2024 – con la durata quasi trentennale dell’attività della Fondazione; un’attività svolta attraverso convegni di alto livello culturale e scientifico, pubblicazioni numerose ed importanti, incontri con il mondo della scuola, dai gradi più bassi fino alle Università più rinomate, il tutto accompagnato dall’eco sulla grande stampa e sulle televisioni, fino alle diverse edizioni del “prestigioso Premio Corrado Alvaro”, per usare le espressioni della stessa Prefettura, che, paradossalmente, lo ha utilizzato come prova a carico anziché a discarico.
Attività che presa sia singolarmente che complessivamente ha colto in pieno lo scopo perseguito dalla Fondazione. Tre le “criticità” rilevate: la prima fa riferimento ad “iniziative episodiche e circoscritte, insufficienti al raggiungimento degli scopi statutari”. La censura, non solo è generica ma è adottata esercitando una discrezionalità tecnica in un settore altamente specialistico, com’è certamente quello storico-letterario e della promozione culturale che, istituzionalmente, non appartiene ad un ufficio generalista com’è una Prefettura. Sarebbe come pretendere dalla stessa una valutazione di tipo tecnico sulla produttività di un istituto scolastico, di un dipartimento universitario, di un Museo, o sulla qualità dei percorsi diagnostici e terapeutici di un ospedale. Tale valutazione, pertanto, prima che giusta o sbagliata, è priva in radice del carattere della stretta giuridicità che, in questo ambito, non può non essere fondata sulla competenza tecnica. La seconda riguarda l’andamento negativo dei conti. Non c’è dubbio che tale rilievo è il prodotto di un fraintendimento in ordine al tipo di Fondazione che abbiamo di fronte. Tradizionalmente tali enti – soggetti privati esercenti pubbliche funzioni – sorgono per gestire patrimoni, economicamente importanti, destinati 2 da qualcuno, talvolta anche dallo Stato (si pensi alle Fondazioni bancarie o agli Enti lirici), al raggiungimento di determinate finalità. Quasi sempre si tratta di patrimoni che auto-generano reddito (proprietà immobiliari, quote azionarie, depositi bancari e postali, presìdi di arte e spettacolo) e che quindi consentono una gestione più tranquilla e soprattutto autonoma. Questo come tutti sanno non è il caso della Fondazione Alvaro, che nacque ed ha vissuto grazie alla generosità del più puro volontariato, mosso esclusivamente dall’ammirazione e dall’amore nei confronti del grande Sanluchese e dai contributi quasi sempre di provenienza regionale. Una volta chiusi questi rubinetti, appunto dal 2019, è derivato ineluttabilmente il rallentamento delle attività. Sulla terza “criticità”, relativa a nudi ed improduttivi legami di parentela di due amministratori con soggetti “controindicati”, non mette conto riferire. Tale riferimento, segno di debolezza argomentativa, prima che infondato è costituzionalmente inammissibile. Chiudendo, non si può non esprimere un pensiero ai tanti volontari della Fondazione, quelli di oggi e quelli di ieri. Ad essi, finché è vissuto, è stato vicino, riconoscente per tanto genuino sforzo, don Massimo Alvaro, il fratello prete di Corrado Alvaro.
Avv. Francesco Macrì