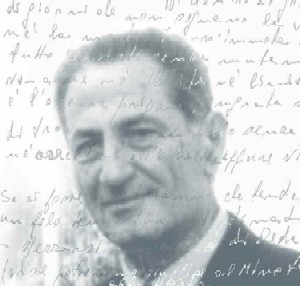R. e P.
La poesia di Enzo Agostino (1937-2003) appartiene a quella schiera, preziosa, di figure appartate, nell’opera nascosta di una scrittura in quella riflessa e creaturale risonanza del mondo accessibile solo nel suo ascolto misurato, nella silenziosa e invisibile posa della sua parola.
Uomo e insegnante coltissimo, amministratore e politico ancora apprezzato e ricordato nella sua Locride, solo nell’età matura la sua opera infatti ha avuto dignità di pubblicazione e questo data anche la naturale ritrosia del carattere grazie soprattutto alla spinta dei cari amici fiorentini, su tutti Giovanna Fozzer, Margherita Pieracci Harwell e Renzo Gherardini che ben conoscendo la bellezza e la forza del dettato dopo essersi adoperati per una edizione dei testi ne hanno poi curato anche dopo la morte dell’autore la fortuna critica. Tanto si è scritto e si è parlato di questa poesia i cui testi, per la gran parte a dire la verità andati dispersi, ora è possibile leggere in due pubblicazioni, in Inganni del tempo (2004) sempre per la Polistampa e in questo Coccia nt’o gramoni in cui è racchiusa la produzione nel dialetto della natia e amata Gioiosa Jonica. Se di caso Enzo Agostino è bene parlare in una poetica cui tanta attenzione critica ha provato ad analizzare dalla fedeltà ad una tradizione ferma ai colpi delle tante correnti, dei tanti ismi del novecento ma aperta e sciolta alle verità di una parola più che moderna nei suoi incontri e nelle sue rivisitazioni autoriali (da Montale a Luzi nella prossimità dei nomi dai più rivelati) più proficuo ci appare allora intanto in essa perdersi per meglio comprenderne nella dialettica dei suoi opposti distanze e direzioni, tra filosofiche e metafisiche carnalità di congiunzione oscurità e bagliori di un canto proprio, solo in questo nella sua splendente e dolente richiesta di vita, e insieme di congedo, esattamente riconoscibile, nella sua sostanza unico. Ed è questa poesia pur nell’inseguimento a disperdersi dei suoi elementi e delle sue invocazioni una poesia degli spazi e del tempo, un tempo nell’incisione del richiamo, dell’incipit nella battuta a rinsaldarlo, a fermarlo nella sua possibilità di verso: è autunno, è inverno, è mezzanotte, è vespro, albeggia, è mezzogiorno, brucia l’estate, così tra interni e strade, vicoli di una geografia di paese ben definita nei suoi luoghi cardine (il Castello, le contrade di Giardini e Chiusa, il Santuario di San Rocco), il la nelle strofe di una esistenza avvertita in tutta la sua impossibile e impassibile bellezza, di una vita a cui solo può una contemplata e inarrivabile consegna.
E la consegna come detto è quella dell’invocazione e della lode, l’uomo a perder misura- nella illusione di una sua riconquista- solo in questa tensione, in questa espansione di odori, colori, voci e profumi che tra dilatazione di stelle e di terre sembrano dirci e aggiungerci entro una pronuncia più alta tra mura e cuore tra ragione e urgenza nel patto sempre vivo con la morte. L’identificazione col paesaggio che avviene per trasfigurazione racconta dunque del tempo, pur nella stizza di un mistero a tratti incomprensibile, l’umile remissione al suo labirinto e insieme la sua accettazione, il limite umano compreso tra nostalgia e sua rottura in una memoria che nell’abbraccio lo va a superare, forse non più relitto ma di quella stessa memoria necessario frammento. Come necessario frammento, così saldamente compiuto nella millenaria cucitura dei riferimenti, ci appare questa Calabria arcaica, questa Calabria magnogreca e saracena , contadina, assalita da malinconie e turbamenti, riflessa solo a se stessa, che Agostino magistralmente sa riportare nella immedesimata speranza di una rinascenza non più nella secca della coercizione e della violenza, finalmente in un destino di navigazione libera, il Mezzogiorno, la storia ritrovata con onestà a viso aperto non più nella servitù di un destino che la vuole chiusa al progresso. Ed allora ci sembra questa poesia profondamente greca, classica proprio nella consapevolezza di un dirsi infinito che solo nell’infinito del canto sa la sua sopravvivenza, soprattutto la sopravvivenza dei suoi motivi a non perdersi, a non cessare nella richiesta di una luce che viene dalla notte, la notte allora per questo tema e momento cardine della sensuale passionalità del suo autore. Casa sua allora d’eremita come di convento (“mura ‘i ‘stu cumbentu”), o come di cane nel tormento di zecche in un mare di pescecani, sembra questo continuo rimandarsi nel giro di un destino di cui si sa prigioniero, nella dimensione di un buio da cui alla luce ora nel ritrarsi ora nell’evocazione ama, sa la necessità del riaffacciarsi. Di fuori è il ritorno eterno della vita in tutti i suoi esercizi e le sue suggestioni, il suo negarci entro una condizione che ci vuole finiti ma anche riaffermati proprio nelle forme di una mortalità cadenzata nell’insieme delle sue incarnazioni, dell’amore soprattutto ed è per questo che Agostino curiosamente finisce coll’apparire tragicamente poeta vero proprio nel dire e cercare la vita nel disperare di un sorriso tenuto per sé là dove la vita è insieme nel suo annuncio e nella sua negazione, nella sua rinnovata mancanza. Ci domandiamo allora quanto abbia senso parlare in lui di contrasti, di opposizioni che pure ci sono, è vero e sono fortissime, e quanto invece non si debba più semplicemente rivelare la lotta e il contrasto con un’esistenza riportata nel groviglio impossibile delle sue accezioni, delle sue luci e dei suoi pesi cui solo la parola può innalzare e renderla ancora là dove nasce nell’ispirata malia di un Dio che ora appare e dispare. Parola musicalissima, ricchissima e allusivamente gioiosa anche nelle intemperanze, nelle recriminazioni delle sue ombre cui ora con rabbia ora con mistico slancio va a diluirsi come ben rivelato all’interno da Gherardini nell’offerta entro una “lingua insolita,misteriosa nella sua chiarezza di suoni e di colore, tutta asperità e dolcezza insieme, nulla di più diretto all’orecchio, all’animo.(..) Dono di una espressività nuova, tutta verginità fonica e visiva”. Augurando allora maggiore attenzione e rinnovata fortuna a questo “breve canzoniere d’amore e di morte” (come nella giusta definizione della Fozzer nella nota di chiusura) ci andiamo a lasciare affondando con lui come bambini nel cuore di una reciproca ninnananna di dimenticanze e desideri:”Dormi, ch’o cori meu/t’annaca e ti cunsola,/joca nt’o sonnu, abbola,/dormi, e dormu puru eu” (“Dormi che il cuore mio/ti culla e ti consola,/gioca nel sonno, vola,/dormi, e dormirò anche io”).
Gian Piero STEFANONI- lucaniart
Coccia nt’o gramoni, Edizioni Polistampa, Firenze, 2003.